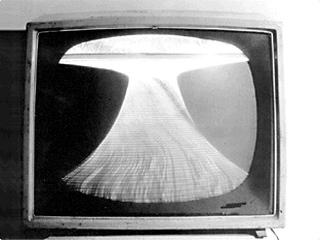L'OFFICINA DELLE IDEE
Floc'h e Rivière, restando legati alla tradizione franco-belga della linea chiara, hanno introdotto nel fumetto le sperimentazioni formali del Nouveau roman e sono riusciti nell'intento di creare un legame inscindibile tra il fumetto e la letteratura. Matteo Stefanelli si occupa di sociologia dei media e ha curato programmi televisivi e mostre sul fumetto contemporaneo.
NB: Per alcuni approfondimenti discussi nella seguente intervista, si consiglia di leggere prima i tre libri che compongono Una trilogia inglese.
MATTEO STEFANELLI: Fin dalle prime battute
L'appuntamento a Sevenoaks offre un tuffo nell'Inghilterra degli anni Cinquanta.
FLOC'H: Vorrei subito chiarire un fatto. Anche l'amicizia tra me e François Rivière, mio compa gno di lavoro da allora, deriva dalla nostra anglo filia. Per quanto mi riguarda, mi piace definirmi "anglolatra", derivando la parola da idolatra. Questo perché ritengo che anglofilia non sia abbastanza forte. Fin da bambino ero convinto che le targhe delle vie britanniche fossero di una bellezza e un'armonia grandiose, mentre quelle francesi orribili. La bandiera britannica, la Union Jack, mi pareva formidabile, mentre il tricolore francese orribile. E cosi via per le finestre, le porte e innumerevoli particolari. Non saprei dire perché si diventi anglofili fino a questo punto. Ma per me era così. E anche per Rivière, anche se in modo differente. Come mi diverto spesso a dire, se lui è come Miss Marple, io sono il il gio vane gentleman pallido in stile Grandi speranze di Dickens.
M.: Quali aspetti la colpivano maggiormente, nel tem peramento britannico?
F.: Ho sempre preferito Londra a Parigi. Se guar date Londra, o più in generale l'Inghilterra, pote te notare come essa sia un teatro, ben più di Parigi. In Inghilterra ci sono, a mio avviso, più possibilità di finzione. Per fare un esempio: sono stati gli inglesi ad avere inventato le case delle bambole, che sintetizzano l'idea stessa del "rac conto nel racconto", e dell"immagine nell'immagine" che in francese chiamiamo mise en abyme. E posso aggiungere che adoro la letteratu ra inglese, mentre quella francese non mi tocca. In quella inglese c'è già una "distanza" dalle cose che non appartiene alla tradizione francese. Penso per esempio a Noel Coward, o a P.G. Wodehouse, un maestro assoluto. La sua scrittu ra è magnifica, ma non può scrivere seriamente come un francese: i francesi sono troppo seri.
M.: Nell'arena del fumetto contemporaneo erano e
sono particolarmente rari i riferimenti allo spirito bri
tish e alla sua tradizione narrativa.
F.: Già, che esperienza avevamo dell'anglofilia nel fumetto? Praticamente il solo Edgar P. Jacobs, l'autore (belga) della storica serie Blake & Mortimer... Che era però avventura... Noi arri vammo, però, trent'anni dopo Jacobs e il nostro era evidentemente un approccio nuovo. Non avevamo fatto parte direttamente di quell'univer so culturale, per questo avevamo necessariamen te una certa ironia. Eravamo anche i figli degli anni Settanta, e non parlo di Carnaby Street e della cretineria hippie, ma piuttosto di artisti come David Hockney, che aveva già fatto un film intitolato A bigger splash.
Anche nel cinema, tutto era divenuto più com plesso ed elaborato. Ci interessavano film, storie e approcci differenti. C'era attenzione per una costruzione "speciale" delle storie: non si poteva più essere solo lineari, e ciò che abbiamo intro dotto nel fumetto era l'idea di rompere con la linearità del racconto.
M.: Negli anni Settanta il fumetto europeo era forte mente polarizzato. Da un lato la grande tradizione avventurosa, dall'altro la sperimentazione radicale, da Métal Hurlant a Cannibale. Il vostro lavoro invece proponeva una logica diversa dallo "scontro culturale" praticato dagli sperimentatori più polemici.
F.: Condivido pienamente. Non avrei mai fatto fumetto se non fossi arrivato con un'idea nuova. Le nostre intenzioni e riferimenti erano altrove. Ve ne erano fondamentalmente di due tipi..
Da un lato c'era il movimento del cosiddetto Nouveau roman, con Alain Robbe-Grillet e altri, che aveva elaborato una scrittura più complessa. Dall'altro, c'era un rapporto naturale con l'arte contemporanea. Rispetto ai tempi di Hergé, l'au tore di Tintin, che pure era un grande amante dell'arte contemporanea, per noi e altri della mia generazione era qualcosa di molto più integrato nel nostro modo di fare e vedere le cose.
Conoscevamo molto bene Roy Liechtenstein e la pop art era qualcosa di ormai assimilato. Avendo dunque digerito tutto questo in lettera tura e in arte, non potevamo più scrivere un fumetto in modo "frontale". Era evidente che lo avremmo affrontato in modo laterale. Per certi versi, non eravamo più naïf: c'era una distanza che faceva si che cercassimo magari del l'ironia, ma senza fare cose già fatte. C'è una definizione che ho sempre amato, a proposito del dandismo: "il dandismo si prende gioco della regola, ma la rispetta ancora”. Questo è ciò che abbiamo fatto noi, rispetto all'esistente. Ciò che invece si prendeva gioco toralmente della regola, come gli autori della rivista L'echo des satanes, per me non aveva valore. Affinché qual cosa possa avere valore, bisogna rispettarne la regola.
M. L'esperienza artistica di Hergé, il creatore di
Tintin, sembrava già così lontana?
F.: Per Hergé la vicenda dell'arte contemporanea era separata dalla sua esperienza. Quando andai a trovarlo nel 1975 nel suo ufficio, aveva appese alle pareti alcune serigrafie di Liechtenstein, cin que o sei, immense, di quelle con il lavoro sulla cattedrale di Rouen già trattata da Monet. Quindi era culturalmente molto aggiornato: nel suo ufficio aveva ciò che c'era di più moderno all'epoca. Tuttavia diceva che lui si sforzava di fare della pittura moderna, realizzando alcune tele, ma che non ci riusciva, ed era condannato a scrivere delle storie. In effetti Hergé, come anche Jacobs, erano stati segnati e influenzati dalla cultura dei feuilletion, che avevano letto da giovani, mentre noi abbiamo avuto influenze molto più moderne.
Certo non bisogna dimenticare che Hergé ha fatto un libro molto moderno: I gioielli della Castafiore. Una storia di Tintin che non è fatta d'altro che di continue "piste false".
Non ho mai capito, infatti, come sia stato pos sibile per lui, dopo quel lavoro, regredire e fare I libri che ha fatto. Mi immaginavo che sarebbe andato ancora oltre. E invece viene da chieder si se non si sia trattato di un "incidente". Per Rivière e me, voler tradurre gli stimoli del rac conto contemporaneo è invece una volontà totale.
M. Com'è nata l'idea di Appuntamento a Sevenoaks?
F: La racconto dall'inizio. Quando incontral Rivière studiavo arte all'École des Arts Décoratifs a Parigi. Avevo visto un annuncio da parte di un editore che era in cerca di illustratori.
Presso questo editore lavora va François, come redattore, occupandosi delle riedizioni di Maurice Leblanc o di Lovecraft. Nel dossier cher presenti all'editore c'era un disegno che lo aveva affa scinato: ritraeva la mia fidanzata di allora, che era sul letto e leggeva L'enigma di Atlantide di Jacobs, la più nota delle avventure di Blake & Mortimer. Oggi potrà sem brare sciocco, ma allora una scena del genere suonava piuttosto nuova, come qualcosa di paradossale. E così iniziai a fare qualche coper tina per lui.
A quei tempi Rivière aveva scritto solo un libro, ma come critico. Si intitolava La scuola di Hergé.
E dunque aveva conosciuto e discusso a lungo con lui. Un giorno François mi propose di incontrare Hergé - un invito che nessuno avreb be rifiutato - e partimmo per Bruxelles. In treno, durante il viaggio di ritorno che allora durava tre o quattro ore, mi raccontò l'idea di un libro che aveva in testa. Era la trama di Appuntamento a Sevenoaks. In quel periodo io non volevo fare fumetto tanto per farlo: non volevamo fare gli artigiani, ma gli artisti. E allora gli dissi: «Facciamone un fumetto». In quegli anni, essere autori di fumetto o di fantascienza era quanto di meglio ci fosse, una cosa eccitantissima...
M.: La vostra storia esordi sulle pagine della rivista più celebre e fortunata dell'epoca, Pilote. Ne era direttore René Goscinny, creatore di Astérix, ma anche noto scopritore di talenti.
F.: Quando nel 1976 L'appuntamento a Sevenoaks uscì a puntate su Pilote, Goscinny ci chiese di fare una pagina di presentazione del libro. Per lui il nostro lavoro era decisamente nuovo e temeva che i lettori ne sarebbero rimasti scioc cati. Si preoccupò quindi di spendere una pagina per avvisarli su cosa gli sarebbe accaduto. E non tanto per gli omicidi o gli aspetti più gore presenti nella storia: quel che temeva era la
novità relativa alla costruzione narrativa, che
non si era mai vista prima. Ricordo, infatti, che
all'uscita di Appuntamento a Sevenoaks ricevem mo delle critiche molto buone, ma il pubblico fece più fatica. I lettori si accontentavano del l'esistente e non capirono molto della storia. Una di queste critiche diceva più o meno così: "I bambini non capiranno nulla. E i genitori avranno invece interesse a rileggerla. Perché siamo davanti, qui, a una spirale senza fine, come in certi scritti di José Luis Borges". Era una delle prime volte in cui si parlava di fumet to e, insieme, di letteratura.
M.: In quegli anni il fumetto popolare stava vivendo una profonda maturazione nei contenuti, sempre più attenti alla realtà sociale e all'attualità. Eppure la tradizione europea era ancora fortemente standardiz zata, sul piano formale.
F.: Devo dire che, ancora oggi, non mi pare che nel fumetto sia stato fatto molto per renderlo adulto. Molti autori sono rimasti incollati all'av ventura. Un aspetto fondamentale che ho intro dotto, anche se non da subito nei primi libri, è stata l'eliminazione di tanti elementi tipici del fumetto, come il "cattivo" che è sempre presente nelle storie. Queste sono cose che non mi inte ressano. Oggi questo non si può fare. È davvero bizzarro, ma anche per il regi sta Alain Resnais andò allo stesso modo. Ci siamo cono sciuti molto tempo dopo, quando mi chiamò per lavora re sui suoi film, ma le nostre esperienze furono molto simi li, perché Resnais stava scrivendo e realizzando un film che aveva la stessa struttura di Appuntamento a Sevenoaks nello stesso momento esatto in cui noi lo stavamo facendo, senza però che nessuno di noi fosse a conoscenza del lavoro dell'altro. Nel suo caso il film era Providence, la storia di uno scrittore che sta per iniziare il suo nuovo romanzo e che, siccome sa che sta per morire, mescola elementi reali della sua vita con quelli di finzione. Quando usci in sala, come per la nostra storia, la gente non capi nulla perché il pubblico non può ammettere che la realtà sia negli ultimi cinque minuti del film, o nelle ulti me due pagine del libro.
M.: E nelle ultime pagine L'appuntamento a Sevenoaks si rivela per quello che è: non solo un gial lo, ma un "racconto nel racconto". Un racconto specu lare che gioca con le attese del lettore, per spiazzarlo e smascherare la natura stessa del raccontare: una fin zione. Ma una finzione credibile.
F.: Da parte mia, il vero lavoro artistico è iniziato quando ho avuto l'idea di questa trilogia e ho voluto creare una prefazio ne generale ad essa [uscita nel 1992 come racconto illustrato, dal titolo A proposito di Francis, N.d.R.J. Si tratta va di un elogio funebre, una lunga lettera biogra fica di Olivia indirizzata a Francis in occasione della morte di quest'ultimo. Una delle ragioni era quella di rendere esplicito che non ero un passatista, uno che amava Jacobs e scriveva storie in quella direzione. Volevo che fosse evidente il mio approccio "moderno", dunque trovai la soluzione di ri-raccontare le vicende della trilogia integrandole con gli episodi della vita di Francis, mescolandole a fatti e persone reali, come artisti e scrittori realmente esistiti. Tutto questo per indicare che i nostri personaggi erano vivi: solo nel momento in cui si apprende la loro morte, come un fatto dell'anno in corso, capiamo che hanno una vita vera. Non come quegli eroi del fumetto che non invecchiano... La scelta del rac conto poliziesco era ancora una maniera di pra ticare questo gioco: scrivere una storia che pare poliziesca per fare scoprire che si tratta di qualcosa d'altro.
Evocavamo poco fa I gioielli della Castafiore. L'appuntamento a Sevenoaks è la stessa cosa: piste false in continuazione quindi, ancora, ci prendia mo gioco di cose che conosciamo ma che non vogliamo più fare. E nel libro Les chroniques d'Olivier Alban, che si presenta come un testo sugli amori letterari e artistic scritto a quattro mani da Olivia e Francis, quest'idea è condotta al parossismo. Dunque la triloga e quella prefa tione per me donavano al nostro lavoro una luce del tutto nuova era un modo di trasformare in un "racconto nel racconto non solo una singo la storia, ma tutto il nostro lavoro.
M.: Qual era, e quale continua a esserne, la spirita
che vi guida nel mettere al cen
tra questi aspetti di costruzione
del sacconta? In che misura si
tratta di una passione pura
mente formale?
F. E vero che si tratta di una passione formale. Per me, per esempio, è come quando un pittore astratto ha uno stile e cerca di svilupparlo l'interesse è proprio nel restare ancorato allo stile. perché ciò che ha trovato puo svilupparsi all'infinito. Quando non c'è mise en abyme, come per esempio nel secondo libro della trilogia, Il dossier Harding, per me non c'e molto interesse. Questo non significa che si debba fare della mise en abyme tanto per farla, semplicemente. bisogna essere "nel formale",
ossia attenti alla forma
Ne parlavo con Alain Resnais, che mi diceva che per lui era la stessa cosa: quando si elabora una costruzione narrativa complessa non ci si stanca di quel che si fa perché produce un'eccitatione. Ma non è un'eccitazione che deriva dal sorpren dere il lettore, come accadeva in un nostro lavo to intitolato Blitz. Li sapevamo che avremmo sor preso il pubblico, alla fine.
Si tratta del solo lavoro che abbiamo scritto tenendo conto del contesto della pubblicazione. Era su commissione, e ogni settimana ne veniva pubblicata una pagina, sul quotidiano francese Le Matin. Avevo costruito un'ambientazione sapendo che ne avrei fatto un uso preciso e cal colato. Per esempio, le persone entravano da sinistra verso destra, e se andavano nei loro rivati prendevano la destra. Sapevo che potevo aprire il tale mobile e li c'era radio; che c'era un ufficio, un salone. E soprattutto sapevamo che, alla fine, non si trattava che di un palco teatrale. una
Tutte le persone che erano li non vivevano quindi il "blitz" direttamente, ma interpretavano un copione di teatro sul blitz! Questo è comunque un piacere: il pia cere di una costruzione con una forma precisa.
Si può andare avanti perché ci si appoggia a questa forma, ma poi la scrittura è libera. E questo può avveni re perché c'è una sorta di quadro entro cui si sa dove si va. Preferisco perciò una trappola formale che una trappola di finzione. Per esempio, in Agatha Christie amo l'atmosfera ma non gli intrighi. Detesto ciò che Hitchcock chiamava whodunit, quel concentrarsi di molti polizieschi solamente sul "chi ha sparato". Rivière li ama, ma non io. A me interessa la complessità formale.
M.:Ricordava che all'inizio il vostro lavoro sulla forma non è stato colto da tutti i lettori.
F.: Quando abbiamo fatto questo lavoro, si poteva quasi considerarci underground. Ma non amo essere etichettato da nessuno. Come la celebre frase di Groucho: "Non vorrei mai far parte di un club che accettasse tra i suoi soci uno come me". Non voglio essere underground né classico. E quando si ha una forma come questa, si hanno più probabilità di non essere imprigionati in etichette. Se il nostro lavoro fosse un lavoro tradizionale, andrem mo avanti rapidi e spediti; ma se si ha per le mani una costruzione dalla forma così particolare, lo spirito, l'ecci tazione e la sagacia nel lavo ro restano molto forti. Il nostro lavoro sulla costruzio ne del racconto è talmente importante che pensavo che dopo il nostro libro la narra zione fumettistica non sareb be stata più la stessa; che avremmo aperto un campo di libertà di scrittura formi dabile.
E invece cos'è successo? Dei nostri libri è passato il "lato Tintin". Si è parlato dello stile del segno, la linea chiara, e si è detto: "Ah, guarda... Sono nello stile linea chiara, come Hergé". Dopo di noi, in tantissimi si sono messi a fare ligne claire, ma era un atteggiamento stupido per ché in me la linea chiara nasceva solo dal fatto che faceva parte della mia educazione, ma anche perché mi divertiva l'idea di ingannare le perso
ne con un disegno rassicurante. Molti autori, invece di considerare il nostro lavoro come uno stimolo per dedicarsi a scrivere storie molto complesse, nuove, si sono ispira ti solo al disegno.
M.: Negli anni di Appuntamento a Sevenoaks la "linea chiara" era un fatto ormai storicizzato. Il vostro lavoro apri a una nuova consapevolezza forma le sui suoi usi.
F.: Credo che John Ford sia uno dei migliori cineasti perché non fa movimenti di camera che si vedono troppo. Per me la cosa è simile: il vir tuosismo del disegno non deve prendere troppo spazio. Ciò che mi interessa di gran lunga di più è l'aspetto del l'ellissi narrativa, scrivere il più possibile "tra le vignet te". Un giorno mi chiesero dove avevo fatto progressi nel mio lavoro. La mia rispo sta fu: «Tra le vignette»>.
Il punto era ed è riuscire ad evitare tutti gli scogli di Jacobs, come l'eccesso di parole nelle pagine. Mi inte ressava riuscire a "saltare" da una vignetta all'altra, e - nozione nuova per l'epoca - prendersi il proprio tempo.
Poiché Hergé e Jacobs erano molto attenti alla suspense, la loro idea era di accelerare terribilmente la lettura. Negli anni Settanta però ci
si godeva di più la vita e la mia volontà era di rallentare il ritmo. Volevo fare grandi vignette in cui ci si potesse "sistema re" dentro, come nelle case delle bambole. Volevo che si potesse aprire la porta e che il gruppo di soggetti nel fumetto fosse come cia scuno dei pezzi nella casa delle bambole. Per esempio, una delle cose più deliziose che ho avuto il piacere di fare, in Alla ricerca di Sir Malcom, è di far vedere la grande sala all'epoca
del padre, nel 1912, mentre si è nel 1954.
Questo era una cosa che amavo molto e che Hergé non avrebbe mai fatto... Tranne quando dovette rifare, un po' suo malgrado, L'isola nera e nella riedizione mise una grande vignetta con tutto il salone...
M.: Come lavora alla costruzione grafica della tavo
la? Nel suo lavoro si incontrano spesso geometrie com
positive molto forti.
F.: Rispetto al fumetto, non parlo mai troppo del disegno. Il disegno dell'Appuntamento a Sevenoaks è, per esempio, in molti aspetti mal riuscito. Non sapevo disegnare, e pensavo sareb be venuto facile una volta ideata la storia, inve ce fu durissimo. Nei manifesti, invece, divento un vero e proprio disegnatore.
Nel fumetto l'importante è fare qualcosa che aiuti la narrazione, per esempio quando raccon to il Titanic che affonda in Alla ricerca di Sir Malcom: volevo rappresentare come si fosse pas sati dall'inconsapevolezza al dramma.
All'inizio si vede la nave che si scontra con un
iceberg, poi continuo dolcemente riprendendo
ogni personaggio, per far vedere dov'era in quel momento drammatico. Anche qui era come giocare in una casa delle bambole, ma c'era il bisogno di una narrazione che avanzasse e che avesse ritmo. E il ritmo si produce con l'ellissi. Si è parlato tanto del fumetto come un mezzo imbecille e per bambini, ma il cinema è spesso più imbecille del fumetto, perché quando si è davanti a un film non si ha tempo per pensare. Con il fumetto, invece, i bambini riempiono gli spazi tra le vignette e ci sono molte cose non raccontate tra di esse, dunque è affascinante. Inoltre, il cinema impone un ritmo di lettura, mentre letteratura e fumetto permettono di andare avanti e indietro, accelerare o rallentare.
M.: Qual è dunque la maggiore differenza nell'ap proccio al disegno quando lo affronta da illustratore?
F.: Diciamo che per me la differenza è enorme e minima allo stesso tempo: quello che hanno in comune è la magia di riuscire a creare un'emozione. Anche dare una psicologia degli oggetti, con il minor numero possibile di mezzi: sono sempre stupito dal fatto che se metto dei puntini su un abito la gente dirà: "Ma è del tweed!", quasi fosse un'illusione... La differenza è che sono molto contento di un mio disegno, ad esempio una copertina del New Yorker, perché tutto è controllato, mentre si può dire che nel fumetto non c'è una sola immagine che mi soddisfi per davvero: bisogna avanzare, questo è ciò che conta.
Nel lavoro come illustra tore è sufficiente che il singolo disegno mi soddisfi. Anche nell'ultimo libro, Olivia Sturgess 1914-2004, alla fine in una tavola ho aggiunto il disegno della copertina del catalogo di una mostra che abbiamo fatto su Olivia e Francis. Quel catalogo si che mi incanta perché è in un fumetto, ma è pur sempre illustra zione, e mi ci ritrovo.
M.: Crede che Hergé o Jacobs si ponessero domande simili, e si preoccupassero delle loro performance come disegnatori?
F.: Credo di si... Secondo me si vergognavano un po'! Di Jacobs ne sono certo: a un certo punto non ne poteva più di fare fumetto. Era troppo lungo, come lavoro, e durante la seconda fase della sua carriera non era mai soddisfatto. Per esempio, aveva capito che serviva un nero pesante per far uscire i contorni, ma lui preferiva
va comunque disegnare a matita. Herge invece era più moderno e ne soffriva meno, perché era trascinato dalla forma che utilizzava e quindi pensava subito al libro.
Mi viene in mente un aneddoto: quando lo vidi a Bruxelles, gli portai un volume per farmelo dedicare. Naturalmente avevo scelto accuratamente una prima edizione, di quelle con la copertina opaca e il formato ori ginale. Gli feci notare quindi come fosse triste che, già allora, i nuovi libri - che sono quelli che conosciamo oggi - fossero inutilmente plastifica ti, lucidissimi, ci si poteva versare dell'acqua sopra e sarebbe scivolata via. E sa cosa mi rispo se! Che li trovava come delle caramelle! Piacevoli, quindi. Da quel momento ho capito che non mi sarei mai battuto, riguardo ai libri che avrei realizzato, per ottenere un'edizione "all'antica". Da Hergé imparai una straordinaria lezione di modernità.
M.: È vero, però, che lo stile "linea chiara" pone più problemi in termini di resa narrativa. È uno stile più formale, rispetto ad altri modi di disegnare. E richiede, impo ne un grande controllo.
F. Ha ragione. Ma la cosa più importante è che se non ci fosse quel controllo. perderemmo ciò che conta di più, ovvero la psicologia. La linea chiara richiede molto lavoro perché biso gna assolutamente che si creda alla realtà, che Tintin esista
E c'è ancora più merito a farlo esistere perchè è qual cuno, per esempio, i cui occhi non sono che due puntini. Il minimo sbanda mento spezza la lettura dunque deve sostenersi d più. Il rischio che accompa gna tutto questo e quello d adottare uno stile eccentri co, che è il contrario di quello formale, lo fac cio molta attenzione, per esempio, a fare in modo che lo stile non cambi qua e là. Gli anni Ottanta e Novanta sono stati anni di sperimen tazione, anche un po' pietosa per me, ma in cui tutti avevano voglia di cercare delle cose. Vedevo gli altri intorno a me che deformavano. il disegno, lasciandosi alle spalle l'aspetto for male. Questi autori però hanno lasciato tutti il fumetto. Come Serge Clerc. Gente che è parti ta per la tangente, perché avevano talmente deformato il loro disegno che non si è più potu. to credere loro. La psicologia è svanita e la voglia di leggere le storie non era più forte. lo ho scelto, senza esitazione, che si potesse crede re ai miei disegni. Quando guardo le case delle bambole voglio l'illusione di esserci dentro, di entrare dentro la casa.
M.: Il suo lavoro come illustra tore talvolta ha ben poco di "cre dibile": e l'astrazione a contare.
F.: Del mio lavoro come illu stratore ci sono due parti. Se faccio una copertina per il New Yorker devo raccontare. qualcosa in una immagine e il processo allora sarà simile al fumetto. La piccola sedia. o il gatto, dovrà funzionare come in una casa delle bam bolei deve trasmettere la: voglia di infilarci la mano, di prendere la sedia e farla uscire. Poi c'e un'altra parte, che è quella di diver tirsi a eliminare il più possi bile. In una locandina come quella per Melinda e Melinda di Woody Allen non ho messo che la testa di Allen e due mani che tengono una maschera della commedia e una della tragedia. Mi diverto a togliere di mezzo tutto il resto, per ché quello è un altro mestiere: serve talento da autore di affiche. Quello che conta è andare subi to al cuore della cosa, perché non si ha il tempo a disposizione per un fumetto o un'illustrazione. L'esigenza è opposta: invece di cercare di "siste mare" delle persone dentro a delle scene, qui bisogna "acciuffarle rapidamente.
Matteo Stefanelli
(intervista pubblicata sul
Labels: fumetti, interviste, testi